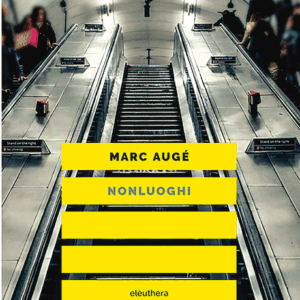Il tema di questo numero induce a una riflessione in particolare sul rapporto tra le città e le loro librerie, inevitabilmente legata da parte mia al rapporto tra la nostra libreria e la nostra città.
Recentemente ho ricevuto in dono il catalogo di una mostra allestita alla locale ‘’Casa dello studente’’ (‘’Grafica europea dalla donazione La Roggia’’) che presenta oltre quattrocento opere tratte dall’archivio grafico della omonima galleria d’arte pordenonese. Nella presentazione dell’elegante volumetto ho trovato un passaggio molto interessante: ‘’…luoghi in cui l’arte aveva un sapore tutto diverso da quello che impastava un po’ la lingua nei musei, forse per eccesso di qualità o forse perché in galleria era come se si potesse bere direttamente dalla bottiglia; luoghi che negli ultimi anni sono andati scomparendo -al pari delle librerie intese quali posti in cui imparare sfogliando e chiacchierando, come e forse più che nelle biblioteche- in parallelo all’imporsi di una logica da distributore automatico, in cui una rassicurante assenza di confronto permette a chiunque di sentirsi saputo’’.
Si tratta di un pensiero piuttosto profondo che fotografa in modo preciso e forse impietoso la realtà di un sistema che ha trasformato e sta trasformando il nostro modo di vivere.
Ci muoviamo in un tipo di società che possiamo definire liquida o dello spettacolo o dell’apparenza.
La chiusa del passaggio che ho citato può apparire fin troppo provocatoria, ma costringe ad una riflessione sincera e precisa. ‘’Sentirsi saputo’’: cosa significa ‘’sapere’’?
Fino a che punto trattiamo ancora il libro come il più importante strumento di diffusione del sapere, seppure non l’unico?
Vorrei proporre una sorta di ‘’formula delle 3 C’’: il libro permette di conoscere, la conoscenza permette di crescere, la crescita permette di confrontarsi…e da questo confronto nasce nuova conoscenza e quindi nuova crescita e quindi ulteriore confronto in un processo circolare privo di soluzione di continuità. Un processo che dovrebbe essere aspirazione di ognuno di noi.
Ma, se il libro deve servire a tutto questo nasce il bisogno di chiederci come dovrebbe essere una libreria, quale ruolo deve avere il libraio, quale rapporto deve e può nascere tra lui e le persone che frequentano il suo spazio.
A questo punto mi permetto di citare alcuni passaggi tratti da un mio articolo uscito nel marzo 2020 per la rivista ‘’La Panarie’’:
‘’…una libreria è un luogo dove si vende un prodotto, ma prima ancora dove si offre un bene, e non un bene qualsiasi bensì lo strumento principe per studiare e crescere, base di sviluppo culturale e conseguentemente di progresso economico…un libraio non può essere il grigio porgitore di una merce, ma deve porsi come propositore culturale…ogni libreria deve avere una sua anima, a partire da una precisa personalità del suo libraio, che non può essere un semplice commesso, bensì un operatore che lavora coscientemente con i libri (perché, i libri possiedono un’anima ed è compito del libraio farla affiorare!)…può essere utopia, ma un mestiere inteso come passione, anche un po’ come missione, deve possedere una carica utopistica…’’ (del resto, si tende a considerare l’utopia come qualcosa di improbabile, ma ‘’improbabile non significa impossibile’’ e certamente essa suscita la spinta necessaria al conseguimento di conquiste progressive, magari piccole ma pur sempre importanti).
Tornando al rapporto tra le città, anche la nostra, ed i vari presidi culturali è accaduto a partire da metà degli anni ottanta, quando si è avviato una sorta di trionfo del capitalismo finanziario, che essi abbiano subito un prima lento e poi sempre più veloce processo involutivo che ha investito appunto gallerie, librerie e vari altri modi di fare cultura. Anche rispetto ad essi hanno preso il sopravvento l’aspetto spettacolare e commerciale. Nelle città sono praticamente scomparse le gallerie e si sono fortemente ridotte le librerie indipendenti, quelle librerie che cercavano e cercano di realizzare gli intenti di cui ho parlato in precedenza. Un fenomeno particolarmente triste è stata la chiusura nel giro di pochi anni di tante ‘’librerie centenarie’’ (Italo Svevo a Trieste, Draghi Randi a Padova, Paravia a Torino, Croce a Roma, Guida a Napoli…): dovremmo interrogarci sul fatto che il nostro paese abbia potuto accettare tutto questo praticamente senza alcuna reazione. Abbiamo perso per sempre un patrimonio importante. E’pur vero che altre librerie sono nate e nasceranno, ma non potranno mai compensare la ricchezza di valori che in esse si incarnava.
Tutto questo ci riconduce necessariamente al mutamento del rapporto tra cittadini e spazi culturali e civili: potremmo ricordare ancora una volta il concetto di ‘’mutazione antropologica’’ usato da Pier Paolo Pasolini negli anni sessanta e settanta.
Per quanto riguarda le librerie pare si stia andando smarrendo il bisogno di un certo tipo di spazio e di operatore. Nasce l’interrogativo su quale sia il tipo di libreria che i lettori, soprattutto quelli potenziali, possano preferire.
Si desidera la grande libreria più o meno ‘’supermercatizzata’’ oppure la libreria di minore estensione ma ancora dotata di un’anima?
Si sente il bisogno di una libreria fascinosa che punta sull’impatto estetico piuttosto che sull’assortimento oppure di una libreria che si sforza il più possibile di avere tanti titoli in modo da garantire un panorama il più possibile variegato?
Si preferisce la libreria ove trovare commessi magari gentili ma non così preparati e motivati oppure la libreria ove incontrare librai disposti ad avviare dialogo, servizio, passione?
Ho parlato di fascino legato ad un certo tipo di immagine, ma esso dovrebbe sostanzialmente essere legato al contenuto dei libri, alla molteplicità di riflessioni che essi permettono, alle occasioni di dialogo e di crescita che da essi possono nascere. Quando per dialogo si intende un processo di confronto e di crescita collettiva, un processo circolare tra editori, scrittori, librai e lettori, senza che qualcuno debba per forza essere più importante degli altri. Pensiamolo pure come un processo democratico ove ognuno può imparare qualcosa dall’altro.
Ebbene, le risposte a tutti questi interrogativi sembrano diventare sempre più complesse. Da un lato abbiamo le librerie indipendenti che stanno scomparendo, o per chiusura o per assorbimento da parte dei grossi gruppi editoriali, e dall’altro lato crescono costantemente le librerie di catena: dunque, pare che il pubblico vada orientandosi verso queste ultime (un dato per tutti: le librerie indipendenti in Italia a fine anni ottanta occupavano circa l’80% del mercato librario, nel 2019 erano scese al 22,6% e a fine 2024 al 12,4% ed anche quest’anno inevitabilmente vanno perdendo ulteriore spazio).
Non intendo certo sostenere che quel tipo di ‘’negozi’’ non siano utili e non svolgano in qualche modo un ruolo di salvaguardia del libro; però il modo è molto, forse troppo diverso. Può essere paradigmatico il percorso delle librerie Feltrinelli: fino agli anni ottanta sono state librerie di tipo tradizionale, molto simili alla nostra attuale, erano librerie in cui anche l’intellettuale entrava per parlare col libraio di libri e dei loro contenuti. In seguito si sono trasformate in luoghi ammiccanti, sempre più vasti ma con minore varietà di volumi per lasciare spazio a tutta una serie di prodotti che libri non sono, dagli oggetti di cartoleria ai prodotti di culinaria. Sono diventate librerie che in vari modi orientano gli acquisti dei clienti verso i cosiddetti ‘’bestseller’’, per i quali i margini di guadagno sono molto più alti, penalizzando tanta letteratura propositiva. Sono librerie che lasciano meno libertà ai loro commessi, i quali sembrano smarrire sempre più la professionalità di libraio.
Tutto bene? Forse si…
Te lo chiedi ogni volta che vedi qualcuno con le loro belle borse, ogni volta che le persone vengono da te in seconda battuta a cercare libri che non hanno trovato da loro oppure a proporre quesiti ai quali loro non hanno potuto o voluto dare risposta. I tempi sono cambiati, sono cambiati un po’ per tutto. I centri delle città presentano una quantità di negozi vuoti, negozi ove prima fervevano attività interessanti. Il tutto a causa e a favore dei centri commerciali, dei supermercati, dei negozi di catena. Perché dovrebbe essere diverso per le librerie? Forse perché il libro non è una merce qualsiasi? Ma questa può essere ormai una concezione ‘’superba’’ di cui non c’è più bisogno. Di fatto, però, nel nostro paese stiamo assistendo ad un progressivo impoverimento culturale.
E allora?
Ho sempre sostenuto che la sopravvivenza di una libreria indipendente è strettamente legata alla volontà del pubblico. Se le persone non ritengono più necessario un certo modo di essere e di lavorare forse dobbiamo convincerci di essere arrivati alla fine di un ciclo, di essere entrati in una nuova epoca che non ha più bisogno di quel ruolo.
I tempi cambiano sempre più velocemente, le generazioni si succedono e mutano i modi di vita: forse quella che noi abbiamo provato a considerare come una missione ormai non è più così necessaria.
I giovani dovranno cercare altri modi e magari ne troveranno di migliori: dobbiamo tutti augurarcelo e spronare loro a pensarli e realizzarli.
Rimangono quelli che io definisco ‘’clienti amici’’, che ancora permettono di trovare soddisfazione e piacere in quello che si fa quotidianamente. Ma è un pubblico che si restringe progressivamente, rendendo abbastanza complicata la nostra sopravvivenza. Alla fine, lo sostengo da molto tempo, questo tipo di clientela renderà possibile la sopravvivenza solo di piccole librerie indipendenti, portate avanti da persone di buona volontà, disposte a lavorare molto a fronte di modesti risultati economici. Fortunatamente qualcuno resisterà; avremo tante, speriamo tante, barchette naviganti in acque agitate. Cerchiamo ancora di immaginare e desiderare una società che possa godere di una costellazione di piccole ma tenaci librerie, anche se il sistema distributivo dominato dai grossi gruppi editoriali pare fare tutto il possibile per impedirlo. Ma c’è anche la possibilità che alla fine prenda forma una società pervasa dalla diffusione di tante ‘’cattedrali nel deserto’’. Il futuro sembra riservarci un mondo piuttosto complicato, ove sempre più il grande prevarica il piccolo e la ricchezza dei pochi aumenta la povertà dei tantSperiamo che almeno in questo tipo di mondo il libro possa continuare a svolgere un ruolo.
Ma sarà una società sempre più povera di luoghi culturali idonei (librerie, gallerie, cinema…), almeno come li abbiamo intesi fino ad oggi. Arriverà altro capace, speriamo, di garantire una certa qualità della vita. Stiamo vivendo una svolta epocale, forse come mai è avvenuto in passato. Tutto è destinato a cambiare: non c’è motivo per cui non debba trasformarsi anche il mondo dei libri e dei librai.
Muteranno in modo sostanziale anche i rapporti tra la città e i suoi abitanti e le relazioni subiranno variazioni oggi imprevedibili.
Sarà un mondo migliore? Non possiamo saperlo, ma dobbiamo continuare a immaginarlo possibile.
Nota: sono molti i libri che affrontano i temi trattati in queste paginette. Mi limito a citarne quattro:
Marc Augé ‘’Nonluoghi’’ (Eleuthera 2024)) a spiegare nascita e crescita di realtà caratterizzate da anonimato e omogeneizzazione
Andrè Schiffrin ‘’Editoria senza editori’’ (Quodlibet 2019) a sottolineare la crisi degli editori di qualità e delle librerie di proposta
Goffredo Fofi ‘’L’oppio del popolo’’ (Eleuthera 2019) a stigmatizzare l’aspetto spettacolare e fuorviante di tante espressioni culturali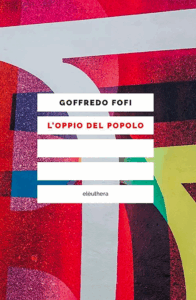
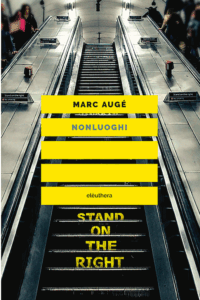
Marino Buzzi ‘’Un altro bestseller e siamo rovinati’’ (Mursia 2012) a sdrammatizzare, ma non più di tanto e con tono ironico, il destino del libraio.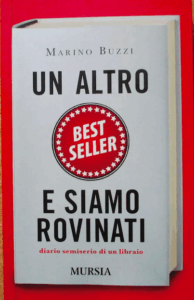
Indice
- Editoriale Città e Relazioni: un mosaico di sguardi. In un periodo...
- “In nome della scandalosa forza rivoluzionaria del passato” È, inaspettatamente, Pier Paolo Pasolini il fil rouge che, nel...
- La moda: un legame tra persone e ambiente Quanto lo stile di una città influenza la moda e...
- La musica transfrontaliera: Gorizia e Nova Gorica “Diversamente giovani”. La battuta, scontata tra quelli che sono diventati...
- Relazioni che trasformano Vogliamo costruire una società inclusiva, con uguali opportunità per tutti...
- Relazioni e geopolitica Quando si parla di relazioni si intende in genere tra...
- Una scultura per Padova L'installazione ha inaugurato un peculiare spazio espositivo voluto da Roberta...
- Quanti sentieri s’incontrano in città Quando, nei primi anni ottanta, assolsi i miei obblighi di...
- L’essenza della relazione Per gli esseri umani i luoghi sono definibili se hanno...
- Arrivare a Itaca Non sappiamo più aspettare. La velocità a cui ci abituano...
- Un’anima nell’ombra Le relazioni umane sono difficili, sono l’intreccio delle nostre personalità...
- La biblioteca scolastica Al giorno d’oggi tendiamo a trascorrere la maggior parte del...
- Vite scolpite, voci di città: relazione tra arte pubblica e paesaggio urbano Un assunto innovativo per l’epoca è quanto postula Gordon Cullen...
- Raccontami di te. Volti e voci che ricuciono la comunità Cosa resta di una mostra dopo la chiusura delle sue...
- Blognotes 20 Set/Ott 2025. Il tema del numero 20 di Blognotes è...